Dalla preistoria al tardo Rinascimento
Una volta che il sole va a dormire, tornando ogni sera nello stesso letto, sente la macanza della donna che mai incontrerà, la luna, che, svegliandosi al suo posto, lascia, oltre ai lenzuoli disordinati, una forte assenza. Vista dalla prospettiva umana, invece, la luna è quella bella, pallida e malinconica fanciulla che possiamo osservare, probabilmente senza nemmeno che lei possa percepire la nostra esistenza, tant’è grande l’universo a confronto. Prima di iniziare il racconto della storia dell’arte, è necessario sintetizzare come a questo satellite vengano associati, ormai quasi da sempre, specifici significati simbolici o addirittura poteri, che l’hanno identificata come la misteriosa responsabile delle maree, dei cambiamenti ciclici, oltre che delle emozioni, dei sentimenti e degli istinti dell’individuo, in particolar modo quello femminile.
Tutte queste responsabilità che sono state attribuite alla luna, trovano ulteriore sviluppo nelle fantasie portate avanti dal racconto delle arti figurative, che, in questo specifico caso, prenderà luogo esclusivamente nel racconto storico-artistico italiano. Prima di adentrarci in questa materia specifica sarà però curioso presentare velocemente l’impatto generale, che il satellite ha avuto nelle manifestazioni creative, riscontrabile sin dalle prime civiltà, ovvero quando l’uomo ha alzato gli occhi al cielo, riportando quella stessa visione nelle sue credenze e nelle sue rappresentazioni, tanto che uno dei primi esempio della luna nell’arte è l’osso di Lebombo, piccolo oggetto portatile di circa 35.000 anni.
Nonostante in questo caso ci troviamo, in realtà, a metà strada tra arte e rappresentazioni della luna, il nostro racconto può procedere fino a 3600 anni fa, epoca in cui è stata realizzata la prima, vera e propria, immagine della luna, che prende forma nel celebre Disco Celeste di Nebra: un cerchio piatto di bronzo decorato con inserti d'oro circolari e a forma di mezzaluna, che potrebbe essere stato usato per osservazioni astronomiche. Successivamente, a proposito del periodo greco, è noto come in questo contesto la luna venisse personificata nella raffigurazione della divinità Selene, personaggio celebre per indossare, appunto, una piccola mezzaluna o un disco lunare nei suoi capelli.
Se nell’antico Impero Romano tale tradizione venne portata avanti, con l’avvento del cristianesimo le cose cambiarono, tanto che la luna trovò ampia popolarità nelle raffigurazioni della crocifissione, dove era posta, sia per tener fede al racconto biblico di oscurità, sia per simboleggiare l’ira cosmica di Dio per la morte del suo unico figlio. In aggiunta, tale presenza potrebbe anche alludere alla Sinagoga, che, insieme alla Chiesa (che prende le sembianze del sole), assiste al suddetto drammatico evento per piangere la morte di Cristo.
Durante il Rinascimento, invece, a tali credenze si sommò anche un discreto interesse di tipo naturalistico, tanto che artisti come Jan van Eyck osservarono la luna con gli strumenti a loro disposizione, al fine di rappresentarla il più fedelmente possibile. Adesso il racconto si ferma, perché sarà l’arte degli artisti italiani dal tardo Rinascimento in poi a spiegarci, concretamente, l’evoluzione del racconto figurativo lunare…
 ESSERE NELLA LUNA 20/02 (2021)Fotografia di Bettina Dupont.
ESSERE NELLA LUNA 20/02 (2021)Fotografia di Bettina Dupont.
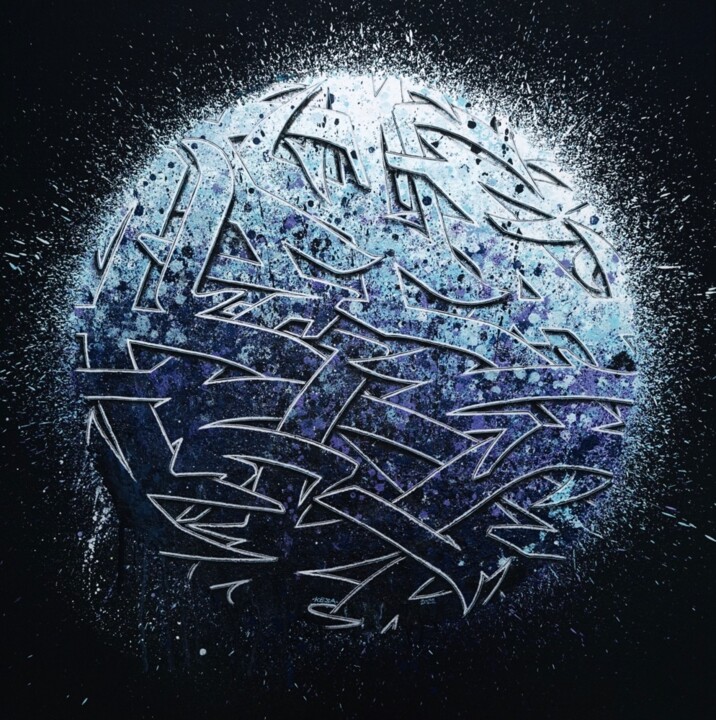 LUNA COSMICA (2022)Dipinto di Kesa Graffiti
LUNA COSMICA (2022)Dipinto di Kesa Graffiti
Pittura: i volti italiani della luna
Quando la luna è vista dal Bel Paese, ovvero quando una delle sue tante facce parla italiano, gli artisti come Cigoli, Guercino, Creti, Canaletto, Fergola e Licini l’hanno raffigurata, realizzando un racconto storico artistico che va dal Seicento sino al Novecento, concretizzatosi nei seguenti capolavori: L’Immacolata concezione (1612), Endimione col cannochiale (1647), Osservazioni astronomiche (1711), La vigilia di Santa Marta (1760), Notturno a Capri (1843) e Amalassunta (1949). Descrivendone tre, al fine di riassumere brevemente questo largo periodo storico, parlerò delle opere del Cigoli, del Canaletto e di Licini, partendo dal primo capolavoro sopra menzionato, dove prende forma una luna che è nota per aver assunto le fattezze di come Galileo Galiei l’aveva descritta nel suo Sidereus nuncius, ovvero quel primo trattato, in cui l’astronomo riportava le sue osservazioni fatte con il cannocchiale.
Di fatto il Cigoli, invece di raffigurare la Vergine intenta a poggiare il piede su di una perfetta falce di luna, e quindi nel rispetto della tradizione dell’epoca, scelse di mostrare le più realistiche irregolarità e crateri di quest’ultima, tanto che Papa Paolo V decise di non azzardare con le iscrizioni presenti nella cupola della Basilica di Santa Maria Maggiore (Roma), dove il capolavori è collocato, preferendo non mostrare espliciti riferimenti al tema dell’Immacolata concezione. Dopo questo aneddoto passiamo rapidamente a Canaletto, maestro la cui produzione risulta essere alquanto ricca di notturni al chiaro di luna, in quanto egli adorava catturare la sua città in occasione delle feste serali, quali, nel caso specifico del dipinto La vigilia di Santa Marta, l’omonima celebrazione, volta a omaggiare la santa patrona dei uno dei quartieri della Serenissima. Proprio in tale occasione, come ben rende il capolavoro, i veneziani solevano godere dei baglori della luna piena, capaci di rischiarare sia i loro profili, che i sussulti del mare.
Infine, a proposito di Amalassunta di Licini, il pittore stesso, rivolgendosi al critico d’arte Giuseppe Marchiori nel 1950, in occasione dell’esposizione del capolavoro in questione presso la Biennale di Venezia, rivelò l’identità del soggetto raffigurato: “Ma, se dovessi mancare e qualche anima curiosa dovesse rivolgersi proprio a Lei, critico d’arte senza macchia e senza paura, per sapere chi è questa misteriosa “Amalassunta” di cui tanto ancora non si parla, risponda pure, a mio nome, senza ombra di dubbio, sorridendo, che Amalassunta è la Luna nostra bella, garantita d’argento per l’eternità, personificata in poche parole, amica di ogni cuore un poco stanco”.
In tale contesto è curioso rivelare come il maestro italiano battezzò con l’appellativo di Amamlasunta la sua icona astrale, al fine di rievocare l’appellativo mariano di Assunta, che venne contaminato con quello della regina ostrogota Amalasunta, dando vita a un gioco di parole che, in bilico tra metafore pagane e cristine, generava una lettura ambivalente del satellite in questione, divenuto, tra l’altro, una figura ambigua in eterna transizione, sempre sospesa tra la sua identità umana e lunare. Siamo adesso giunti alla contemporaneità, che verrà invece narrata mediante il punto di vista di tre artisti di Artmajeur...
 SOTTO LA LUNA ROSSA. (2021)Fotografia di Refat Mamutov
SOTTO LA LUNA ROSSA. (2021)Fotografia di Refat Mamutov
 ASPETTANDO LA LUNA ROSSA (2018)Fotografia di Alessandra Favetto
ASPETTANDO LA LUNA ROSSA (2018)Fotografia di Alessandra Favetto
 NOTTE DI LUNA (2023)Dipinto di Nga Tran
NOTTE DI LUNA (2023)Dipinto di Nga Tran
NOTTE DI LUNA (2023) di Nga Tran
Cala improvvisamente la notte, cogliendo di sopresa un gruppo di cavalli a spasso, che si ritrovano nell’oscurità, solamente illuminati dalla faccia tonda di una luna piena, la cui presenza si impone nell’estremità superiore del dipinto, in prossimità del bordo destro del supporto. In questo contesto tenebroso è difficile comprendere il reale numero dei cavalli in questione, che potrebbero essere circa nove o dieci, tanto i loro corpi si sovrappongono e confondono nella penombra, risultando marroni quelli più vicini e tendenti al blu quelli in lontananza, forse perchè sempre più immersi nelle peculiarità del cielo che li avvolge. È bene sottolineare che quanto appena descritto è un’opera frutto della tecnica d’intaglio su legno, che, facendo riferimento alle parole di Nga Tran, è stata realizzata mediante un ricco disegno e una spiccata capacità di modificare la composizione, raffigurante, in realtà, una coppia di cavalli, probabilmente moltiplicata dalle loro stesse azioni. Il tutto è stato studiato per creare un atmosfera romantica, in cui, sotto il brillare della luna, è ben percepibile la dolce interazione che si manifesta tra le bestie, resa dall’utilizzo di colori fortemente contrastanti, adatti a rendere l’arte quel mezzo di esternazione sentimentale a noi tutti noto. Infine, parlando di Nga Tran, la sua pittura incisa è stata concepita per apportare qualcosa di nuovo alla tradizione artistica vietnamita, che adesso viene anche innovativamente contaminata dallo stile occidentale, al fine di rivelare come le arti figurative, in ogni caso, trovino collocazione nelle cose più semplici, istintive e autentiche della vita.
 SOGNO LUNARE (2023)Dipinto di Marta Zawadzka
SOGNO LUNARE (2023)Dipinto di Marta Zawadzka
SOGNO LUNARE di Marta Zawadzk
“Apollo 11 fu la missione spaziale che portò i primi uomini sulla Luna, gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin, il 20 luglio 1969 alle 20:17:40 UTC. Armstrong fu il primo a mettere piede sul suolo lunare, sei ore dopo l'allunaggio, il 21 luglio alle ore 02:56 UTC…”. È ciatando il testo di Wikipedia che entriamo nel cuore della narrazione a riguardo dell’opera di Zawadzk, pronta a rivelarci quanto i sopra menzionati pittori del Rinascimento italiano potevano soltanto sognare di dipingere: l’effettivo incontro tra l’uomo e il suolo lunare, evento che non avrebbero sicuramente tralasciato dall’immortalare, proprio come ha fatto l’artista di Artmajeur e non solo...Di fatto, prima di lei, precisamente nel 1987, il re della Pop art, Andy Warhol, fu l’artefice di Moonwalk, una serie di due stampe con dettagli in giallo e rosa, volti a dare nuova intepretazione alla fotografia di Buzz Aldrin, che cattura Neil Armstrong mentre cammina sulla luna, nel 1969. Proprio mediante la tecnica della segrafia il maestro americano ha dato nuova vita ad uno dei momenti più celebri della storia dell’umanita, dimostrando come, nonostante il capolavoro sia stato realizzata quasi vent’anni dopo l’episodio, esso risultasse ancora estremamente indelebile e memorabile, oltre che letteralmente “congelato” nella più fresca memoria degli americani. Ad ogni modo però, se proprio vogliamo essere precisi, è bene mettere in luce come il soggetto riprodotto da Zawadzk non sia proprio lo stesso scelto da Warhol, in quanto la pittrice ha tratto ispirazione dallo scatto che Neil Armstrong scattò a Buzz Aldrin, immortalando il pilota mentre si trovava sulla superficie della luna, posto vicino alla gamba del modulo lunare Eagle, durante l'escursione dell'Apollo 11.
 ANIMA PURA (2019)Dipinto di Zsolt Malasits
ANIMA PURA (2019)Dipinto di Zsolt Malasits
ANIMA PURA di Zsolt Malasits
Non è ben chiaro se si tratti di due gemelle o della moltiplicazione della medesima figura, ma, dato che la luna nel cielo è doppia, opterei per la seconda opzione, riconoscendo nell’opera di Malasits un dipinto dagli stilemi surrealisti, volti ad immortalare il momento in cui, con attitudine sognante, ci rivolgiamo alla luna, chiedendo a lei di esaudire qualche nostro desidero. Allo stesso modo, le due effigiate in questione potrebbero anche guardare al satellite, forse riflettendo sul fatto che, probabilmente, proprio nello stesso momento, anche qualche altra anima a loro affine stia contemplando la luna. Tralasciando altre supposizioni, nel lungo racconto della storia dell’arte esiste un noto capolavoro volto a immortalare due figure che conteplano la luna, che, in questo caso, risulta essere però presente in un unica versione. I due soggetti, non “gemelli”, di cui sto parlando sono i protagonisti di Two Men Contemplating the Moon (1819-29), olio su tela di Caspar David Friedrich, raffigurante un paesaggio romantico tedesco, dove, all’interno di una foresta buia, si trovano due figure, che si stagliano su di un cielo pastello, volto a creare un contrasto suggerito da un crepuscolo, arricchito dalla presenza di una luna crescente intenta a tramontare. A contrastare con il chiarore del cielo si aggiungono però anche i frastagliati rami e le radici di un albero morto, la cui esistenza trasforma la composizione, rendendola alquanto minacciosa, inquietante e forse poco sicura per i soggetti ospitati.


 Olimpia Gaia Martinelli
Olimpia Gaia Martinelli